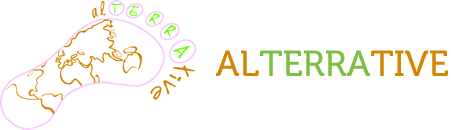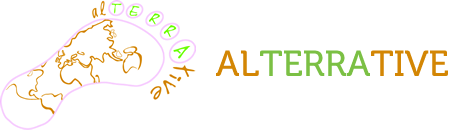Questioni di sicurezza nazionale
Lasciata Lisbona, voliamo sopra l’Oceano Atlantico verso San Francisco. Abbiamo due scali, il primo alle isole Azzorre, il secondo a Boston. Dopo circa 2 ore dalla partenza atterriamo all’aeroporto di Punta Delgada, dove ci viene chiesto di scendere dall’aereo. Prendiamo le nostre cose e in fila ci avviamo verso la sala di attesa dove ci hanno chiesto di aspettare la chiamata per farci tornare a bordo. Nel breve scalo durato poco meno di un’ora, abbiamo dovuto ripetere i controlli di sicurezza, soprattutto Stefano che, fermato dalla polizia, ha dovuto mostrare ogni singola cosa che conteneva il suo zaino. Una volta mostrati tutti gli oggetti ed essere stato perquisito a fondo, Stefano mi raggiunge ai tavoli del piccolo bar dell’aeroporto dove nel frattempo ho scambiato quattro chiacchere con una signora portoghese che vive ormai da tanti anni a Boston, che mi aveva parlato di come suo figlio e la moglie avessero fatto anche loro l’esperienza di un viaggio intorno al mondo l’anno passato e che ora avevano dovuto fermarsi dato l’arrivo del primo figlio. L’altoparlante annuncia l’apertura del gate, ci riavviamo in coda per salire nuovamente sull’aereo. Altro scalo, Boston. Arrivati in terra statunitense, afferriamo i nostri passaporti e i moduli per il visto che avevamo compilato tramite l’ ESTA – Electronic System for Travel Authorization, programma che permette di fare la richiesta in internet a coloro che hanno la cittadinanza in uno degli stati eleggibili, tra cui l’Italia. La sala per il controllo dei passaporti ci confonde con mille indicazioni e mille percorsi fatti di nastri colorati che dovrebbero indicare la strada ai viaggiatori fino al controllo. Nastri viola, gialli, rossi dove smistatori di folla in giacca nera dividono le persone secondo la propria nazionalità dopo aver effettuato una prima registrazione alle colonnine elettroniche. Ci infiliamo in una fila che non era la nostra, ma per Trusted Travelers, linea gold, di persone fidate che possono passare tranquillamente. Poco gentilmente, il personale ci fa notare il nostro errore e altrettanto poco gentilmente ci mostra le colonnine elettroniche dove inserire il passaporto per fare un controllo self-service. Siamo dietro alla signora Maria, che con i suoi capelli bianchi e gli occhiali spessi fa fatica a capire come ottenere il ticket dalla colonnina. Spazientito l’addetto affianca la signora Maria, parlandole un italiano meccanico le mostra in modo spiccio come fare e fa per lei la procedura, mette il ticket nel suo passaporto e glielo porge. Peccato che la signora Maria, nonostante il nome, non è italiana ma portoghese.
Dalla fila delle colonnine ci spostiamo a quella per il controllo della polizia aeroportuale. Da dietro la sua scrivania l’agente Kenneth, un afro-americano magro, sulla quarantina, dal volto tirato e molto severo, ci guarda con il grugno di chi vuole intimorire e gli occhi accigliati e diffidenti. Afferra di scatto i nostri passaporti, li apre, li piega, li sbatte sul banco. Inizia l’interrogatorio. Mentre i televisori sopra le nostre teste mostrano messaggi sulla sicurezza del paese e immagini di poliziotti sorridenti che gentilmente rispondono alle domande curiose dei bambini che chiedono come mai fanno tante domande, Kenneth ci guarda dritto negli occhi e non sorride mai. Ringhia. Domande secche e asciutte, stile sergente maggior Hartman di Full Metal Jacket ma con meno parolacce. Testa rasata, pelle lucida, mento in fuori. Domande semplici del tipo: “Come ti chiami?”, “Motivo del viaggio?”, “Durata di permanenza negli Stati Uniti?” sembrano difficili e senza risposta. Il modo di scandire le parole e di scrutare le nostre facce dell’agente Kenneth ci facevano sentire come dei fuggitivi che nascondevano chissà quale traffico illecito. Perché siete stati in Sud Sudan? Tunisia? Morocco? Chiede battendo la lingua sul palato. Inebetiti, confusi, ci sentiamo come dentro un film. Rispondiamo un po’ titubanti: “come mi chiamo, (boh…non so, tutti ci chiamano Stefano e Daniela), Amici, (chi noi, no nessuno…) Quando ce ne andiamo (forse il 22, no il 23, ma da dove?). Sudati e col battito cardiaco accelerato piu’ che alla maturita’, alla fine passiamo l’ “esame”. Con sufficienza, Kenneth, timbra e firma i passaporti, facendoci segno di andare semplicemente alzando le sopracciglia con aria di spregio, come a dire, stavolta ce l’avete fatta, ma la prossima… Prima prova negli Stati Uniti superata. Questioni di sicurezza nazionale. Ora dobbiamo trovare il gate della nostra coincidenza per San Francisco. Ci perdiamo nei lunghi corridoi seguendo le indicazioni dell’uno e dell’altro passeggero che ha voluto spiegarci come raggiungerlo. Ci arriviamo dopo un po’ di giri. Tiriamo il fiato. Vorremmo mettere nello stomaco qualcosa mentre aspettiamo il volo ma ci guardiamo intorno e rimaniamo scioccati dai prezzi: compriamo solo una bottiglia di acqua, mezzo litro, 6 dollari, tanto mangeremo in aereo, pensiamo. Oramai e’ sera, saliamo sul volo per San Francisco per le ultime 6 ore che ci separano dalla destinazione finale. Una volta a bordo ci meravigliamo di avere un minischermo a testa a disposizione e già scegliamo il film che avremmo visto in volo: “Selma” un film su Martin Luther King. Non avevamo notato che vicino il piccolo schermo c’era anche la fessura per strisciare la carta di credito: se vuoi vedere un film o uno spettacolo paghi, cosi come paghi per avere la cena a bordo. Spento il video e messo via l’appetito chiudiamo gli occhi e ci addormentiamo stanchi per riaprili solo quando atterriamo, finalmente, a San Francisco.